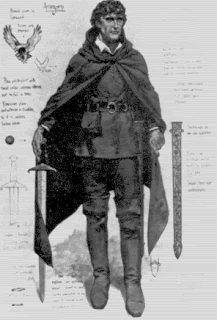Proprio di recente, in seguito ad uno scambio di
mail con i miei amici, mi sono soffermato a riflettere sulla
questione dei
semiumani in AD&D (e l’argomento può ovviamente essere esteso ad altri
sistemi).
Non credo occorra ripetere che AD&D per me
significhi solo la prima edizione!
Veniamo al dunque: i semiumani hanno degli indubbi
vantaggi sugli umani (classi multiple, abilità razziali, bonus a colpire, bonus
alla Classe Armatura e così via), compensati da una più o meno severa
limitazione al livello massimo raggiungibile in determinate classi, nonché l’esclusione
tout court da alcune di esse. Durante gli anni ruggenti delle campagne ad
AD&D con gli amici, ero solito alzare notevolmente i livelli massimi raggiungibili
dai semiumani, e permettere loro l’accesso a quasi tutte le classi. A quei
tempi nessuno avrebbe scelto una razza soltanto per motivi tecnici (per
ottenere qualche bonus, insomma; sì, eravamo degli idealisti ludici), bensì per
ragioni d’interpretazione, e mi sembrava davvero poco corretto che un
personaggio scelto secondo questi criteri subisse una penalità rispetto ad un
personaggio umano.
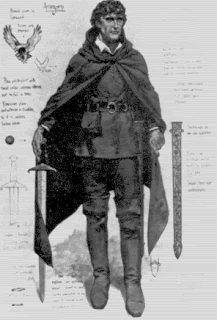 |
| A modo suo, anche Aragorn è un umano! |
Era in vigore anche un’altra regola, ispirata dall’insistenza
con cui Gary, nella DMG, sottolineava la necessità di avere un gruppo “umanocentrico”:
non più di metà del gruppo può essere composto da semiumani. In questo modo si
manteneva un equilibrio interno, e al tempo stesso le campagne restavano in
sintonia con il mondo fantasy nel quale ci muovevamo (che era essenzialmente umanocentrico). Il gruppo di soli
semiumani era riservato, nella nostra fantasia, ad un’ipotetica campagna
specificamente monorazziale: ne giocammo una sola, breve ma divertentissima,
che aveva come oggetto un gruppo di nani di ritorno a casa in un mondo
devastato dalle guerre e da un’imminente catastrofe che l’avrebbe distrutto di
lì a poco. Fu davvero una storia epica, ma come sistema scegliemmo WFRP 2e...
Il gioco comunque funzionava bene nonostante le
modifiche, e i semiumani non erano considerati indebitamente avvantaggiati.
 |
| E poi ci sono loro... |
Di ritorno ad AD&D dopo tanti anni, e dopo
aver riletto con attenzione la DMG (quante regole avevo tralasciato in gioventù!),
decisi che l’innalzamento dei limiti di livello sarebbe stata una delle poche
modifiche da adottare (assieme alla specializzazione nelle armi, che però fu
abolita in tempi brevissimi).
Per svariati motivi, nessuna delle campagne da me
cominciate ad AD&D lo scorso anno aveva la pretesa di essere tale, e così
lasciai ogni volta che i giocatori scegliessero liberamente la classe e la
razza (fatti salvi i requisiti minimi dell’una e dell’altra e le classi
multiple disponibili, queste sì limitate secondo i dettami del PH); mi trovai
così davanti a gruppi decisamente non umanocentrici.
Diversi giocatori preferivano fare l’elfo o il mezzelfo per avere i bonus
conferiti da queste razze, e sia la mancanza di limiti di livello che l’approccio
da “avventura singola” rendevano tale scelta decisamente vantaggiosa (sì, è vero:
le giocatrici tendono a fare comunque le elfe, e solitamente non per i bonus;
forse anche questo mistero della psiche femminile richiederebbe un post). Io rimasi
ingenuamente stupito: come si può scegliere una razza per il solo, arido,
beneficio tecnico? Mi tornavano alla mente i consigli del mio amico Andrea, il
quale insisteva che a Baldur’s Gate creassi un personaggio elfo perché più
forte, e poi lo trattassi alla stregua di un umano, a partire dal ritratto; io
per parte mia mi ritraevo con obbrobrio da una simile, empia prospettiva...
Ed ecco profilarsi un motivo per i severi limiti
imposti ai semiumani dal PH: è una questione di bilanciamento (sorpresa!).
Nelle mie prossime campagne, quindi:
· In un gruppo non ci potranno essere più
semiumani che umani.
· Queste saranno le limitazioni di classe e livello:
CLASSI ACCESSIBILI
|
Classe
|
Nani
|
Elfi
|
Gnomi
|
Mezzelfi
|
Halfling
|
Mezzorchi
|
Umani
|
Allineamento
|
|
CHIERICO
|
Sì
|
No
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Qualsiasi
|
|
Druido
|
No
|
Sì
|
No
|
Sì
|
No
|
No
|
Sì
|
Neutrale puro
|
|
GUERRIERO
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Qualsiasi
|
|
Paladino
|
No
|
No
|
No
|
No
|
No
|
No
|
Sì
|
Legale buono
|
|
Ranger
|
No
|
Sì
|
No
|
Sì
|
No
|
No
|
Sì
|
Qualsiasi
buono
|
|
MAGO
|
No
|
Sì
|
No
|
Sì
|
No
|
No
|
Sì
|
Qualsiasi
|
|
Illusionista
|
No
|
No
|
Sì
|
No
|
No
|
No
|
Sì
|
Qualsiasi
|
|
LADRO
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Qualsiasi
|
|
Assassino
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
No
|
Sì
|
Sì
|
Qualsiasi
malvagio
|
LIMITAZIONI DI LIVELLO
|
Classe
|
Nani
|
Elfi
|
Gnomi
|
Mezzelfi
|
Halfling
|
Mezzorchi
|
|
CHIERICO
|
8
|
-
|
7
|
5
|
6
|
4
|
|
Druido
|
-
|
7
|
-
|
IL
|
-
|
-
|
|
GUERRIERO
|
9
|
7
|
6
|
8
|
6
|
10
|
|
Paladino
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ranger
|
-
|
8
|
-
|
8
|
-
|
-
|
|
MAGO
|
-
|
11
|
-
|
8
|
-
|
-
|
|
Illusionista
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
|
LADRO
|
IL
|
IL
|
IL
|
IL
|
IL
|
8
|
|
Assassino
|
9
|
10
|
8
|
11
|
-
|
IL
|
· I semiumani non multiclasse, con l’esclusione
degli assassini, potranno elevare di due il livello massimo raggiungibile (questa
è forse l’unica regola di Unearthed Arcana che ho deciso di applicare).
· Queste saranno le classi multiple accessibili:
o
Umani – nessuna classe multipla.
o
Elfi – guerriero/mago, guerriero/ladro,
mago/ladro, guerriero/mago/ladro.
o
Nani – guerriero/chierico, guerriero/ladro,
chierico/ladro.
o
Mezzelfi – chierico/guerriero, chierico/ranger,
chierico/mago, chierico/ladro, guerriero/mago, guerriero/ladro, mago/ladro,
chierico/mago/ladro, chierico/guerriero/ladro, chierico/guerriero/mago,
guerriero/mago/ladro.
o
Gnomi – chierico/guerriero, chierico/ladro,
chierico/illusionista, guerriero/illusionista, guerriero/ladro,
ladro/illusionista, chierico/ladro/guerriero, chierico/ladro/illusionista,
guerriero/ladro/illusionista.
o
Halfling – chierico/ladro, guerriero/ladro,
chierico/guerriero.
o
Mezzorchi – guerriero/chierico, guerriero/ladro,
chierico/ladro, chierico/assassino.
Non è mia intenzione applicare retroattivamente
queste regole alle campagne in corso (ma se tutti i giocatori me lo chiedessero
a gran voce... non so bene perché, ma tendo ad escludere una simile
eventualità); sono però convinto che si tratti di una misura necessaria a non
penalizzare i poveri giocatori di personaggi umani.
E qui concludo, ma, come sempre, ogni parere è il benvenuto!